Adesivi | di Simone Rocchi

Lunedì è lunedì anche se sei in smartworking. Come a voler chiarire il concetto, fuori cade una pioggerellina leggera che rende l’idea meglio di qualsiasi altra metafora. Cado subito nel tranello della comodità e lavoro in tuta; una di quelle lucide, vagamente anni ‘80, sintetiche e sicuramente altamente infiammabili. Per tutta la mattinata l’impegno più difficile è quello di non aprire il frigorifero ogni cinque minuti, ma tengo duro e riesco ad essere addirittura produttivo. Prima di cena esco a fare la spesa; la mia ragazza mi ha fornito una lista piuttosto dettagliata, ma non disdegno qualche colpo creativo: quando rientro mi attende al varco. Inizio ad appoggiare i diversi acquisti sul tavolo, decantandone le rispettive proprietà benefiche: “ah, antiossidanti”, “migliora la flora intestinale”. Si tratta perlopiù di effetti inesistenti, ma in questo momento serve fare morale. Vado avanti per almeno cinque minuti e la faccio ridere. E se ride lei rido sempre anche io. Di rimando. Nel profondo. Il martedì c’è il sole e mi concedo una passeggiata al tramonto. Ovviamente con la mascherina. Pochi passi in quello che somiglia allo scenario di un film post apocalittico: silenzio, nessuna auto in giro e i pochi umani che incrocio cambiano lato del marciapiede. La mia città sta soffrendo, letteralmente, e a me viene un groppo in gola che fatico a respirare. E gli occhi lucidi, di impotenza. Prendo quasi subito la via di casa. Ma cammino piano e mi perdo nello scoprire che la mia città ha adesivi ovunque: sulle auto, sulle vetrine dei negozi, sui cartelli stradali; piccoli messaggi in codice per rapire, per un secondo soltanto, la nostra attenzione: per invitarci a fare un tatuaggio, per sostenere un gruppo ultrà o per indurci ad un uso smodato del peperoncino. Sono tutti bellissimi e si sono presi un pezzo, silenzioso, del ricordo di questo momento. Un sorriso utile, ma che non dura, perché la settimana continua così, col silenzio rotto solo dalla fretta delle ambulanze. In casa ce la mettiamo tutta, teniamo duro. Mercoledì scopro che la mia compagna si è iscritta ad un corso di fitness on line. Solo che non ha i pesi e allora allena le braccia con due bottiglie di Campari. Speriamo che non si guasti: per gli aperitivi, per DOPO. La seconda sortita me la concedo di venerdì, subito dopo aver spento il pc. Dopo qualche minuto scopro che mi sono proprio fatto un bel regalo. Perché trovo tutte le piazze deserte e l’incontro tra l’ultima luce del giorno e la prima, tenute, alba dei lampioni. È talmente bello che rimango a guardare senza scattare nemmeno una foto, una cosa che non si usa più. Riprendo a camminare. In Corso Garibaldi vedo tre o quattro persone con la testa per aria: da una finestra del terzo piano sbuca il busto di un ragazzo sulla trentina, che imbraccia una chitarra. Sta cantando Bob Dylan. Solo una volta rientrato scopro che quella della musica dai balconi era una cosa organizzata: chi ne è capace suona uno strumento, mentre per tutti gli altri c’è comunque la manopola dello stereo. Ai tempi di Spotify e YouTube molti decidono di mettere l’Inno di Mameli. In un Paese che di solito si ricorda di saperlo a memoria solo quando gioca la Nazionale. Nemmeno il tempo di scuotere la testa che arriva il sabato. Divano, articoli da scrivere e un sole pallido che filtra dalla finestra. Arriva sera che manco te ne accorgi. Abbiamo appuntamento on line con alcuni amici. Per raccontarci, tramite le webcam, quegli abbracci che fisicamente non possiamo ancora darci. Una birra, due patatine e proviamo a giocare a Pictionary. Quando viene il mio turno disegno un ippopotamo che gli altri scambiano per il Brucomela di Gardaland. Ma succedeva anche prima. La mia squadra, ovviamente, perde. Abbiamo riso, almeno un po’. E per fortuna, domani, possiamo riposare.
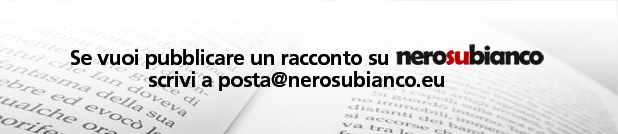
20 marzo 2020 – © Riproduzione riservata





