Don Domenico | di Fausto Bolinesi
Non ricordo il giorno, e di preciso nemmeno l’anno. Ricordo però che era il mese di marzo: il mio primo turno di Guardia medica dalle otto di sera alle otto del mattino.
Era l’epoca, in un certo senso eroica, degli albori di questo servizio: la sede non era collegata neanche a una linea telefonica. Però era il tempo in cui la borsa del medico era veramente la borsa del medico, contenente, cioè, oltre allo strumentario indispensabile per valutare i parametri vitali, anche i farmaci utili per fronteggiare un’emergenza. Non era diventata ancora, come oggi, la borsa del burocrate nella quale i farmaci sono spariti, il timbro è diventato più importante del fonendoscopio ed i pazienti sono codici fiscali e non persone.
Erano anche gli anni in cui il primo lavoro era proprio il servizio di Guardia medica, il che equivaleva a mandare in trincea in prima linea, senza addestramento, un soldato appena arruolato. Ma non era il mio caso per due motivi: il primo è che avevo già ricevuto il battesimo della “trincea”, per due mesi, nel presidio di Guardia medica in una località turistica e il secondo è che provenivo dal tirocinio di un anno presso un reparto di rianimazione e terapia intensiva. Avvertivo quindi la tensione della prima volta, ma non l’ansia, per questo ero nel dormiveglia quando, nel cuore della notte, sentii bussare alla porta…
La casa comunale, sede del presidio, distava meno di duecento metri dalla Casa canonica dove abitava chi si era sentito male: era Don Domenico, il mitico parroco del paese.
Avevo sempre sentito parlare di lui e lo immaginavo, come forse era anche in realtà, alto, imponente, con la veste talare e la berretta. Me lo ritrovavo invece in pigiama, a terra, riverso su un fianco. Parlava. Leggermente confuso, ma parlava. Non mi ci volle molto a capire che era stato colpito da un ictus all’emisfero destro che aveva paralizzato l’emilato sinistro e quindi risparmiato, per sua fortuna, il centro del linguaggio. Feci presente ai familiari, mentre lo adagiavamo sul letto, della necessità di un ricovero ospedaliero. Quasi scusandosi, mi dissero che stavano attendendo anche il suo medico curante anch’esso avvertito. La qual cosa, lungi dall’infastidirmi, mi fece piacere non solo perché avrei condiviso la responsabilità della decisione, ma anche perché dimostrava che esisteva un rapporto di fiducia medico-paziente.
Naturalmente il collega confermò la diagnosi, non perché fossi bravo, ma perché il caso era semplice. Discutemmo anche della terapia che potevamo istituire subito dal momento che, come ho detto, la borsa del medico allora conteneva anche i farmaci per l’emergenza ed io avevo perfino qualche ago cannula. Ma più che a due, fu un consulto a tre: Don Domenico, abituato a decidere più che a subire le decisioni, commentava e annuiva. Ricordo che fu d’accordo sull’uso del Lasix, che lui chiamava Laxis: “Sì, il Laxis è buono”, ripeteva.
In quegli anni il servizio di emergenza, il 118, non esisteva, ma per fortuna in paese c’era un’ambulanza gestita da una associazione cattolica di volontariato: non era l’ambulanza dell’ “Addio alle armi” di Hemingway, ma poco ci mancava. Dovetti decidere se lasciare scoperto il servizio di guardia medica e accompagnare il paziente in ospedale. Di fronte a un evento certo, un paziente con un ictus in atto, e una probabile nuova chiamata, optai per il certo e salii sull’ambulanza.
Lungo il tragitto controllavo spesso il polso di Don Domenico, che nel frattempo avevo collegato ad una bombola di ossigeno e che continuava a parlare. Per mia fortuna, perché in questo modo mi rassicurava che il danno cerebrale era per lo meno stabile. In un primo momento, da come e da quanto parlava, ho pensato che non si fosse reso conto di essere su un’ambulanza, ma poi sono giunto alla conclusione che lui era fatto proprio così. Anche nella vita quotidiana non era mai sceso dal pulpito o dall’altare e secondo me aveva interpretato l’ordinazione sacerdotale come un’autorizzazione, una patente a dare ordini: obbediva forse a Dio, ma non certo agli uomini ai quali imponeva anche il nome di battesimo da dare ai neonati, quando non riteneva adatto quello scelto dai genitori. Il tragitto verso l’ospedale durò circa mezz’ora e sono certo che se fosse durato di più, mi avrebbe anche confessato.
Al ritorno, seduto questa volta accanto all’autista, al chiarore dell’alba osservavo le nuvole che preannunciavano una giornata grigia e anonima di tardo inverno o inizio primavera. Ma per me non fu tale. Provavo una piacevole sensazione dovuta allo sciogliersi della tensione, che comunque c’era fino al momento in cui avevo affidato il paziente ai colleghi dell’ospedale, unita alla soddisfazione di essere stato in qualche modo utile. A questo si aggiungeva il piacere di avere conosciuto, pure se in circostanze drammatiche, un personaggio, come già detto, mitico del quale avevo sempre sentito parlare.
Tornato in sede annotai sul registro: “D. P. Domenico: Ictus cerebrale, predisposto ricovero ospedaliero”. Le sue condizioni nei giorni successivi si aggravarono e dopo circa una settimana scese dal pulpito e dall’altare, dove era sempre vissuto, per salire, spero per lui, verso un luogo ben più importante.
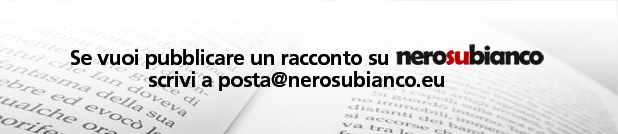
1 ottobre 2022 – © riproduzione riservata





